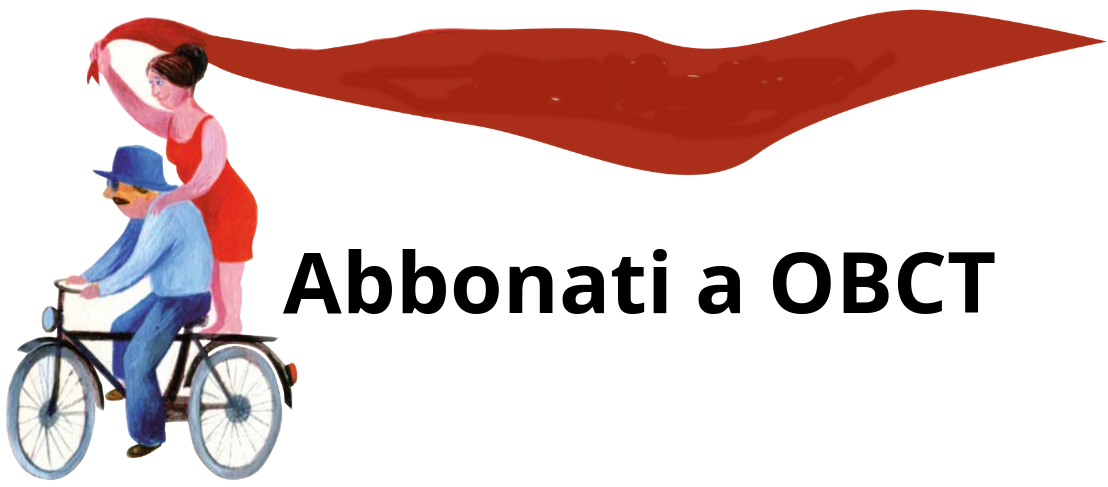Ho una foto, salvata nel telefono. Ci sono io, stretto nella mia t-shirt dei Pink Floyd, a fianco di Jovan Divjak. Lui ha la stessa espressione vista migliaia di volte, un misto di serietà e tranquillità e fiducia che si riesce incredibilmente a ritrovare anche in tante immagini degli anni dell'assedio di Sarajevo, anche in quelle scattate nei momenti più difficili. Io: beh, io ho il sorriso vagamente incredulo di un ragazzino che si ritrova a dieci centimetri da una rockstar planetaria (e già il fatto che sorrido in una fotografia, sì, è abbastanza eccezionale).
Mi aveva portato al suo cospetto Asim pochi minuti prima: “Generale, le presento un nostro amico italiano che vorrebbe tanto salutarla” e lui era stato cordiale, mi aveva stretto la mano con quella benna che aveva stretto mitra e accarezzato bambini, mi aveva parlato in italiano, mi aveva detto che sarebbe venuto a Milano qualche mese dopo.
Di quei pochi minuti nel centro della Baščaršija di Sarajevo ricordo la sensazione di solidità della sua persona e soprattutto il fatto che i passanti si fermavano a decine a salutare, chi gli diceva grazie e chi lo toccava sulla spalla come se fosse una reliquia vivente e lui rispondeva a tutti, a tutti faceva un cenno o rivolgeva un saluto o un ringraziamento.
Ancora oggi, dopo quasi due anni, mi capita di ripensare a quel momento realizzando che non sono mai stato così vicino a una manifestazione di affetto e riconoscenza come quella alla quale ho assistito in quel giorno di agosto in Bosnia.
Un amico mi ha scritto: "Stavo leggendo un po' di social e news sulla morte di Divjak. E' impressionante. Non credo che esista un altro uomo, oggi, così universalmente amato e stimato dalla sua comunità". Erano - sono - un amore e una stima meritati: perché per quella gente, tutta, senza distinzioni di sesso, nazionalità o religione, il generale Jovan Divjak aveva rischiato tutto quello che aveva, a partire dalla vita.
Non era stata una storia d'amore tutta rose e fiori, quella del generale con Sarajevo; ma alla fine il tempo gli aveva reso giustizia; ho passato giorni a chiedermi se io, dall’alto della mia mezza età e della mia informazione e del mio spirito critico così ben addestrato dalla frequentazione con la politica del mio paese quel giorno nel centro di Sarajevo non mi sono lasciato affascinare e incantare dalla vicinanza a un mito costruito con perizia da una delle molte macchine di propaganda che si sono talvolta affrontate e talvolta spalleggiate in quel lunghissimo, estenuante e non ancora concluso conflitto. E oggi che Jovan Divjak non c'è più continuo a sentirmi dalla parte della ragione, continuo a pensare di aver incontrato e stretto la mano a un uomo che, al netto degli errori che chiunque commette e delle decisioni inevitabilmente sporche alle quali ti costringe la guerra, ha scelto la parte giusta: o meglio, la parte della giustizia, che non è la stessa cosa anche se non ho abbastanza parole valide per spiegare la differenza: e sono contento di averlo fatto.
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!