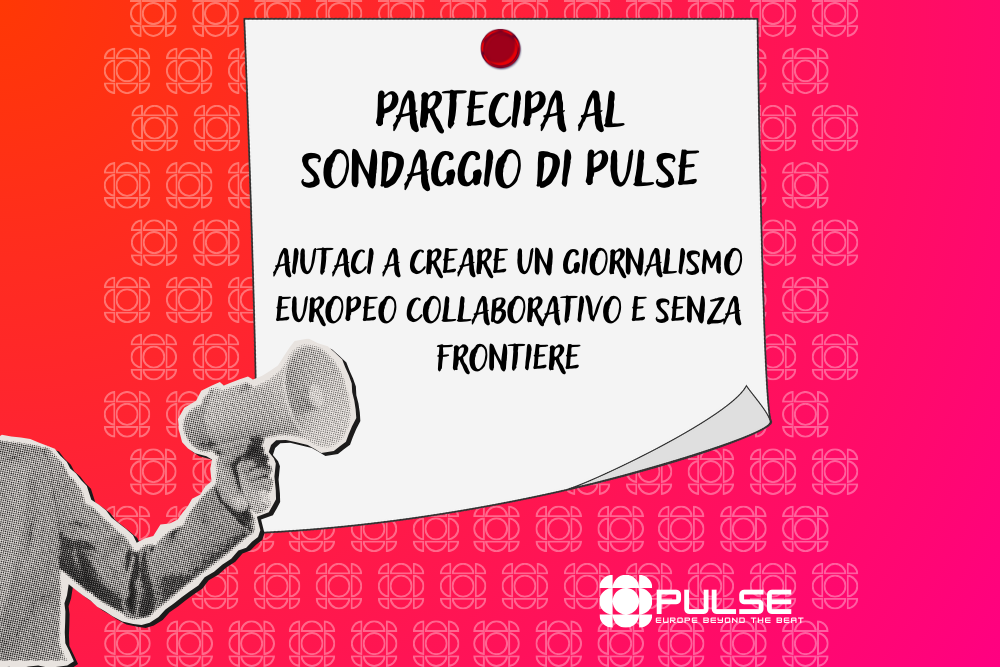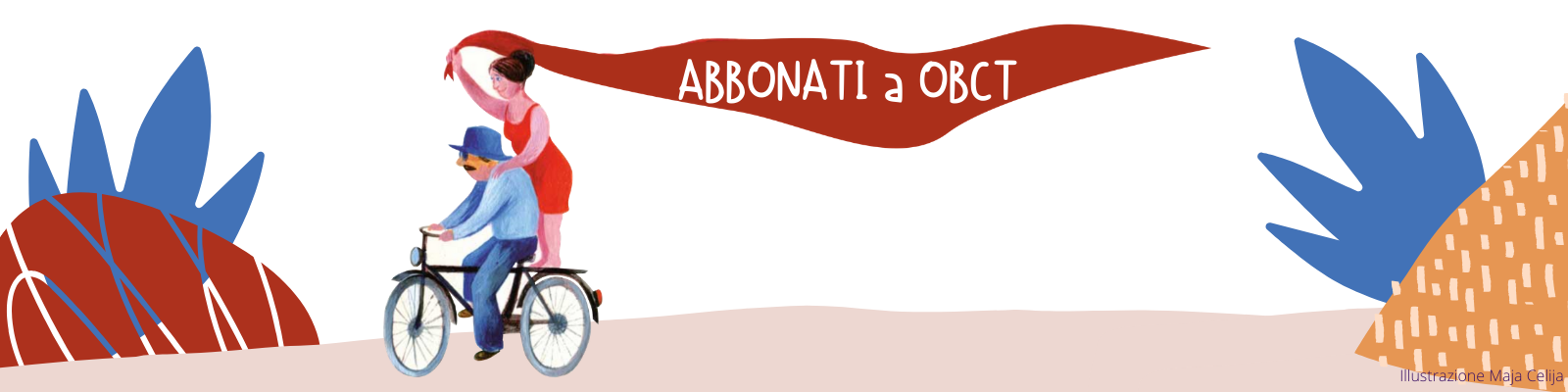Francesco alle porte d’Europa
Dopo la morte di Papa Francesco, il nostro Božidar Stanišić ci riporta alle immagini – potenti e simboliche – del suo primo viaggio apostolico: quello a Lampedusa, sospesa tra il dolore muto dei migranti e la "globalizzazione dell’indifferenza"

Francesco-alle-porte-d-Europa
Papa Francesco - © Riccardo De Luca - Update/Shutterstock
Appresa la notizia della morte di Papa Francesco, probabilmente seguendo quella “legge delle concatenazioni” tanto cara al poeta Laza Kostić, mi sono tornate in mente le immagini del primo viaggio apostolico del pontefice defunto.
Non preoccupatevi, non sono un credente praticante né tanto meno un agnostico. Quindi, non ho alcuna intenzione di analizzare le sue azioni compiute da capo della Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano, e di certo non intendo approfittare dell’occasione per criticare i vari nani del tradizionalismo di ogni genere, che si erano affrettati a giudicare Francesco prima ancora che il suo corpo si fosse raffreddato, come si suol dire nella mia terra natia.
E le critiche sono state tante, dall’anello papale non forgiato in oro, alle scarpe dell’Uomo che aveva accettato un compito, drammatico nella sua essenza e forse anche tragico in questa fase della Storia nel Movimento senza precedenti.
Quelle immagini?
Lampedusa, 8 luglio 2013. Il primo viaggio apostolico del Papa giunto a Roma dall’altra parte del mondo. Un viaggio compiuto dopo l’ennesimo di una lunga serie di naufragi in cui decine, spesso centinaia, di migranti perdono la vita nelle acque del Mar Mediterraneo. Un mare che Erri De Luca, utilizzando un linguaggio documentaristico più che poetico, ha definito… (Trovate da soli quella sua poesia).
Una visita lampo, annunciata all’ultimo minuto per rispettare il desiderio di Francesco di mantenere la massima discrezione. Per chi volesse ripercorrere quel giorno di luglio, condivido qui il link ad una delle fonti informative.
Quella mattina di luglio, Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa Francesco nella storia della Chiesa, dal ponte di una nave della guardia costiera aveva gettato una corona di fiori nelle acque della parte più meridionale delle Isole Pelagie. Alle sue spalle – una vivace orchestra di sirene provenienti da numerose barche da pesca. Un’immagine che richiama alla mente i racconti evangelici su Gesù e i suoi primi apostoli. I fratelli Pietro e Andrea, come anche Giovanni e Giacomo, erano pescatori. Rischiando di sembrare patetico, sostengo che quella scena non fosse stata casuale, ma profondamente simbolica.
La scorta navale del pontefice comprendeva persone che tante volte – per quanto possibile, seguendo la legge del mare e, naturalmente, del cuore – avevano soccorso i naufraghi. Non è un caso che quel giorno accanto a Papa Francesco non ci fosse nessun politico, né italiano, né europeo, né tanto meno un rappresentante dell’Onu. Nessuno a versare qualche lacrima – di coccodrillo ovviamente – su quella nave della guardia costiera, davanti alle telecamere. Semplicemente, non erano stati invitati quelli le cui parole risuonano come bombe a vuoto.
Non c’era nessuno. Solo Giuseppina Nicolini, l’allora sindaca di Lampedusa, che ho avuto l’onore di conoscere in occasione di una delle conferenze organizzate dal Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano.
Solo lei e Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento. “Tutto in perfetto stile Bergoglio!”, avrebbe detto qualcuno.
Quella a Lampedusa era stata più di una semplice visita ad un luogo che in tempi remoti offriva un rifugio ai popoli antichi – Fenici, Greci, Romani e Arabi – per riposarsi durante i loro viaggi di mare. E la Parola, chiara e incisiva, con cui il pontefice aveva sollecitato una trasformazione spirituale e morale, in quel luogo che molti chiamano “Porta d’Europa”.
Naturalmente, questa porta ha il suo lato meridionale, quindi è anche una porta africana – la porta dell’inferno delle guerre e della povertà – che masse di disperati cercano di varcare per raggiungere l’Europa. Quella stessa Europa dove la maggior parte della popolazione non vuole scervellarsi e rovinare l’umore con la spiacevole questione dei migranti.
Sì, quell’Europa (e l’Occidente) che non si preoccupa minimamente della cooperazione con gli ultimi della Terra lasciando loro solo le briciole, continua ad insistere sulle proprie radici cristiane per futili scopi politici, trovando però il suo dio (o Vitello d’oro) nel consumismo.
Giunto a quella Porta, quel giorno, davanti ai migranti e alla popolazione di Lampedusa, Francesco non si era limitato a recitare una preghiera. Aveva pronunciato un vero e proprio discorso sulla “globalizzazione dell’indifferenza” e sulle sue ripercussioni sull’agire etico e politico e, implicitamente, sulla difficoltà e la responsabilità dell’essere cristiani e umani. Ma come possiamo essere cristiani e umani se coltiviamo una memoria selettiva e ipocrita dimenticando che il Figlio di Dio è nato migrante, da una madre rifugiata di Nazareth?
Per Francesco il seme della speranza era nell’atto dell’accogliere l’altro, nel rifiuto di stare con le braccia conserte e di distogliere lo sguardo dai diversi e dagli ultimi. Lo hanno accusato (conosciamo bene i nomi, non li cito per non rovinare questo articolo) di voler portare l’intera Africa in Italia, ignorando il fatto – di cui il pontefice era ben consapevole – che le migrazioni sono frutto di un’immane ingiustizia economica e politica nei confronti degli ultimi. Credo che Francesco sapesse che la giustizia consisteva anche nel permettere alle persone di vivere dignitosamente nel loro paese di origine.
Giacché ho menzionato Gesù, nato in quella stalla misera, Gesù migrante, non posso non ricordare almeno alcuni dei tragici episodi della vita dei migranti sulla cosiddetta rotta balcanica. Ho conosciuto le storie di questi migranti parlando direttamente con loro o guardando documentari e reportage. E ho pensato – in un’ottica letteraria, ma non solo – che dal Vardar al Triglav ci fosse la tendenza a distogliere lo sguardo dai migranti, come se noi, ex jugoslavi, e i nostri discendenti, dispersi in tutta Europa, fossimo diversi e migliori dei migranti rinchiusi nel campo di Lipa (vicino a Bihać) e di quelli che aspettano il momento giusto per provare ad attraversare le recinzioni di filo spinato lungo i confini ungheresi, sloveni e bulgari. Non so come i poliziotti croati, che picchiano i migranti e strappano i loro passaporti, riescano a dormire, né tanto meno posso immaginare quali sogni facciano.
Forse è ingiusto puntare il dito solo contro i poliziotti croati, forse anche gli altri si comporterebbero allo stesso modo se dovessero ricevere gli stessi ordini. Non dimentichiamo però anche quei “meravigliosi” tassisti macedoni, kosovari e serbi e altri “trasportatori” che si sono arricchiti dando un passaggio ai migranti. Ho visto per caso i piedi di un migrante afghano. Ve li descrivo? Oppure non c’è bisogno? Grazie per la comprensione. Resto convinto: quei piedi sono due specchi, rivolti a noi.
Ma come questi poliziotti e trafficanti festeggiano il Natale? E quelli che nella gerarchia di comando – come sempre accaduto negli ultimi cinquemila anni – sostengono di aver solo fatto il loro lavoro? E tutti gli altri cittadini “pii”, dal Vardar al Triglav?
C’è un altro interrogativo che mi assilla, una perplessità molto realistica, anche se qualcuno potrebbe essere portato a collegarla principalmente all’ambito letterario: queste persone sono piene di pregiudizi o semplicemente indifferenti? Voglio però ricordare anche quei cittadini e le associazioni che si battono contro questo fenomeno dell’(auto)deumanizzazione.
Mi fermo qui.
Prima però di concludere questo articolo, non posso fare a meno di dubitare della sua efficacia. Forse aveva ragione Crnjanski quando, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, da funzionario diplomatico del Regno di Jugoslavia, alla domanda di alcuni conoscenti su cosa pensasse dell’allora pontefice, rispose laconicamente: “Il Papa è un’autorità”.
Un aspetto però riesce a fugare il miei dubbi: Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto il nome di Francesco in onore di Francesco d’Assisi, non è stato solo un papa.
In evidenza
- Partecipa al sondaggio