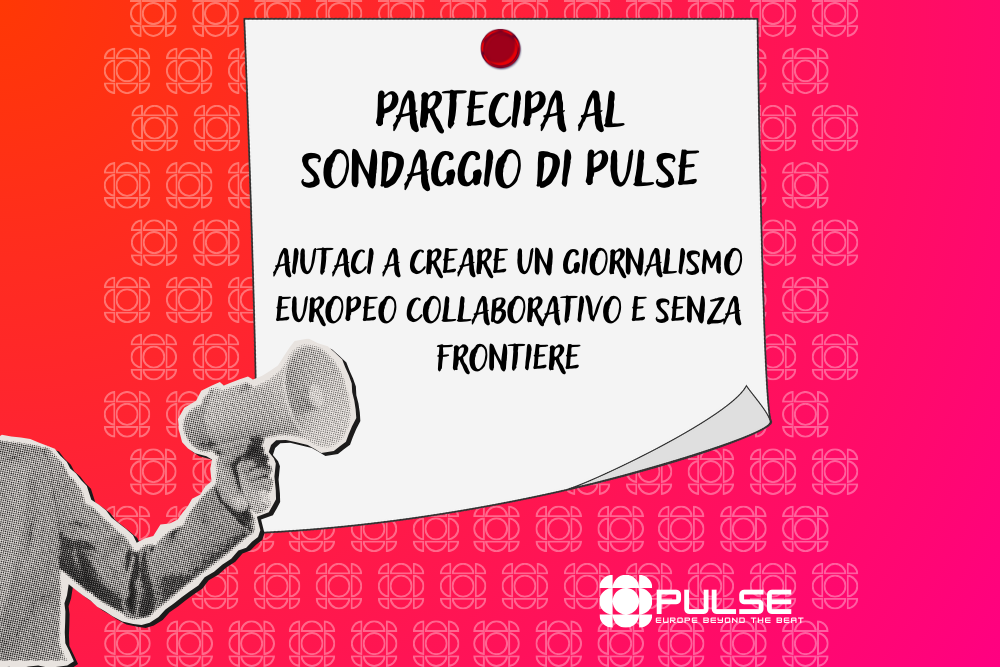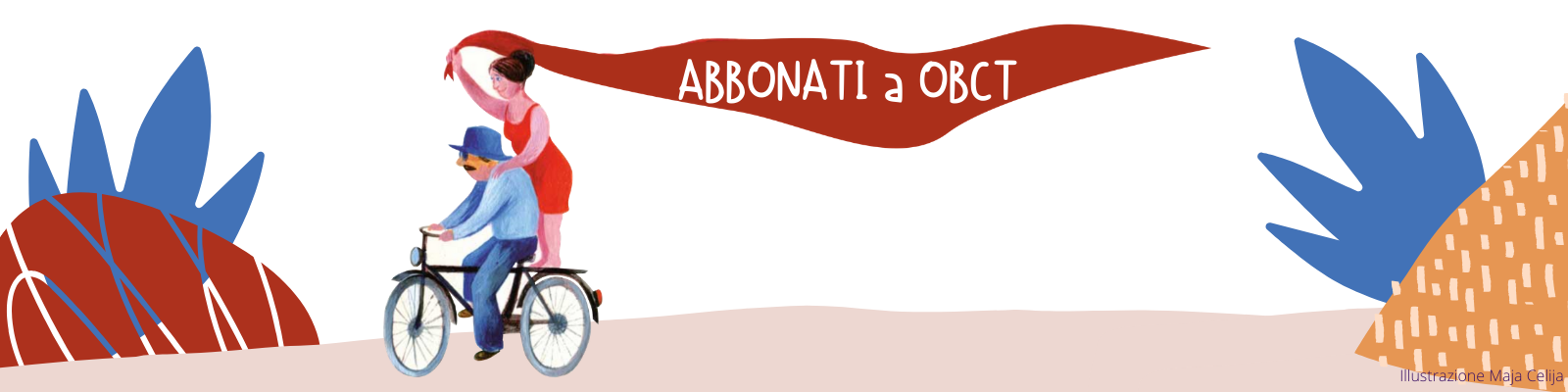Bogdan Crețu, amare tra le rovine del comunismo romeno
Il romanzo "Meno dell’amore" (Mai puțin decât dragostea) di Bogdan Crețu, pubblicato nel 2023, è stato inserito quest’anno nella shortlist del Premio Europeo per la Letteratura (EUP). La recensione del romanzo ancora inedito in Italia

Bogdan-Cre-u-amare-tra-le-rovine-del-comunismo-romeno
Orologio vecchio stile a Bucarest, Romania - © Creative Lab/Shutterstock
“Meno dell’amore” è, al di là di ogni riconoscimento, un libro necessario perché affronta il rimosso, ciò che una società tende a dimenticare per sopravvivere. È una preziosa occasione per conoscere un pezzo di storia. È un’opera che interroga, commuove, disturba e – soprattutto – fa riflettere.
Si inserisce in quella corrente di "postmemoria" che ha visto negli ultimi anni molti autori dell’Europa dell’Est – da Herta Müller a Katja Petrowskaja – cercando di raccontare le storie rimaste nell’ombra del Novecento.
Contesto storico: la Romania tra dittatura e postcomunismo
La Romania ha vissuto una delle dittature più dure dell’Europa orientale, culminata con il regime di Nicolae Ceaușescu (1965-1989). Caratterizzato da un controllo oppressivo della società, da persecuzioni politiche e dalla famigerata polizia segreta Securitate, il periodo comunista ha lasciato un’impronta profonda sulla memoria collettiva del Paese. Il sistema carcerario, in particolare, è stato teatro di torture, lavaggi del cervello e violenze sistematiche, soprattutto durante gli anni ’50.
La caduta del regime, avvenuta nel dicembre 1989, ha segnato formalmente la fine della dittatura, ma il passaggio alla democrazia è stato lento, doloroso e spesso ambiguo. Molti carnefici non sono stati processati, e la giustizia transizionale è rimasta parziale.
Questa eredità irrisolta è al centro del romanzo di Crețu, che pone al lettore una domanda cruciale: come possiamo convivere con il passato se non lo affrontiamo davvero?
La trama: amore, memoria, colpa
Vlad, il personaggio narratore, incontra Maria e in due giorni iniziano a raccontarsi la storia delle loro vite. Quello che all’inizio sembra l’avvicinamento dell’innamoramento diventa una scusa per un profondo tuffo nel passato.
Vlad racconta la sua storia d’amore con Sara, dai tempi del liceo a allo stesso tempo il destino dei propri genitori. Apprendiamo che il padre di Vlad era stato un prigioniero politico che era stato arrestato da adolescente nel 1956 dopo aver cantato “Deșteaptă-te, române!” (l’inno nazionale, vietato in quel momento dal regime).
Bastava davvero poco per essere imprigionati e subire percosse e torture durante il periodo più buio dell’oppressione comunista. L’autore cerca di immedesimarsi nei panni dei carcerieri, riflettendo la complessità umana delle situazioni: il tormento, la soddisfazione o persino il peso interiore che, ironicamente, può provare anche un torturatore.
“Come diavolo puoi calpestare un bambino?” si legge nel libro. “Cosa ci guadagni? Che soddisfazione puoi avere? Cosa si risveglia dentro di te? Bastava sputargli addosso e sarebbe crollato. Oppure alzare il pugno e si sarebbe fatto la pipì addosso. Si vedeva che a casa non lo aveva mai picchiato nessuno. Forse non aveva un padre. Una femminuccia. Ma gli ordini erano ordini, le direttive dovevano essere eseguite. Dovevano ancora consegnare almeno venti casi entro la fine del mese, e questo andava liscio, senza troppi grattacapi. Anche loro si stancavano a forza di urlare. E in questo caso, non c’era nemmeno troppo lavoro da fare: uno schiaffo ben piazzato, un pugno nello stomaco, un calcio nello stinco e fine. Con questi piccoli ci arrivi subito dove vuoi. Era divertente, si rilassavano anche loro un po’. Perché altrimenti non è un lavoro per chiunque: dare pugni, schiaffi, calci, colpi di manganello giorno e notte – credi sia facile? Essere sempre coperti di sangue, come un macellaio. Tornavano a casa, dalle mogli, esausti, distrutti da quanto avevano bestemmiato e picchiato. Che se le scopasse chi poteva, loro volevano solo dormire. E cosa dovevano rispondere quando le mogli chiedevano: ‘Sei stanco? Com’è andata oggi?’ Ah, benissimo, abbiamo picchiato dieci nemici del popolo, quattro giovani e sei vecchi.”
I racconti dei tempi passati in prigione non costruiscono solo delle schede di personaggi, ma restituiscono la realtà di un passato non troppo lontano: “Esiste una realtà del detenuto ed esiste una realtà del carceriere. Per molti, la prima cancella la seconda. In breve, il torturatore picchia selvaggiamente o uccide il detenuto secondo il proprio capriccio. Ma dobbiamo tener conto di entrambe, se vogliamo comprendere la realtà del carcere, del campo di prigionia.”
E per comprendere questa realtà, l’intreccio dei destini dei personaggi diventa la chiave del libro. Il carceriere e torturatore comunista del padre di Vlad risulta essere stato il padre di Sara.
Un torturatore noto, di nome Iancu Iacoban, che tratta il giovane prigioniero con più tenerezza. Non tanto per scelta personale, quanto perché, a quanto pare, era stato l’amico dell’attuale moglie – anche lei incarcerata per un breve periodo e poi liberata, sotto pressione affinché firmasse dichiarazioni contro le proprie convinzioni.
La memoria intergenerazionale si insinua come un albero dalle ramificazioni sempre crescenti. Chissà quanti dei nostri parenti, ai tempi del comunismo, sono stati sia vittime che carnefici.
Personaggi come il torturatore Iancu Iacoban non sono mai stati puniti. La vecchia Securitate romena si è infiltrata silenziosamente nel nuovo sistema. Anche se in qualche raro caso la giustizia è riuscita a portare in tribunale alcuni dei carcerieri, processare dei novantenni non ha avuto molto senso.
La punizione per Iancu Iacoban arriva attraverso sua figlia Sara, che si innamora del figlio della sua vittima, scappa con lui, rimane incinta e, dopo essere scoperti, accetta la promessa d’aiuto del padre per costruirsi una famiglia – solo per fuggire di nuovo, dal paese e dalla propria storia d’amore.
I protagonisti non sono responsabili dei crimini dei loro padri, ma ne ereditano le conseguenze. E una storia d’amore non può costruirsi sulle rovine di un passato pesante. La separazione dei giovani innamorati, che si ritrovano dopo decenni, diventa un sacrificio simbolico di una lotta persa, ma al contempo anche vinta.
Al di là della storia di prigione, tortura e amore, c’è anche quella di Maria, l’interlocutrice del protagonista. La sua non è più una narrazione di violenza fisica, ma di pura miseria e pressione psicologica.
Diversamente da Sara, che ha vissuto nella prosperità grazie al lavoro ambiguo del padre, Maria trascorre un’infanzia e un’adolescenza sordide, con due genitori che fingono di essere felici nel fine settimana – finché nemmeno quello è più possibile. Durante il resto della settimana, si cerca nella monnezza e ci si ubriaca con disinfettante al posto dell’alcol. È così che il padre di Maria pone fine alla propria vita.
“Che amore, eh? Quando sei povero e non hai nulla da mettere in tavola (…) chi dovrebbe insegnarci cos’è l’amore? Odio. E paura. Paura e odio. Con queste siamo cresciuti.”
Il male e i personaggi ambigui continuano a farsi il proprio ruolo al di là di ogni regime. L’influenza del movimento #MeToo nella parte finale del romanzo in un racconto universitario di Maria, introduce un elemento contemporaneo e globale, dimostrando come le dinamiche di abuso e potere non siano confinate al passato.
“Il male – racconta l’autore in un incontro con i suoi lettori – è un tema molto più visibile rispetto al bene. Il bene diventa subito banale, lo dimentichiamo più facilmente. È dal male del passato collettivo che possiamo imparare molto, un male che non è poi così lontano nel tempo. E se questo male non è ancora abbastanza distante nel passato, allora che almeno lo sia nel futuro. L’amore cerca sempre di sopravvivere, ma da solo non basta a guarire le ferite, se prima non si attraversa la verità”.
L’autore
Bogdan Crețu (n. 1978) è professore presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Alexandru Ioan Cuza” di Iași. Tra il 2013 e il 2022 è stato direttore dell’Istituto di Filologia Romena “A. Philippide” dell’Accademia Romena, sezione di Iași. È caporedattore della rivista Timpul e membro di PEN România.
Ha pubblicato otto volumi di critica letteraria, tra cui il più importante è L’unicorno alle Porte dell’Oriente. Il bestiario di Dimitrie Cantemir (seconda edizione, Editura Cartier, 2021). Ha contribuito con numerosi studi a volumi accademici in patria e all’estero, ha curato, editato e scritto prefazioni per diverse antologie.
Tiene una rubrica di critica letteraria sulla rivista Observator cultural.
Per la casa editrice Polirom ha inoltre pubblicato i romanzi Il corno dell’unicorno (2021) e Nichita. Il poeta come il soldato (2022).
Tag: Letteratura
In evidenza
- Partecipa al sondaggio