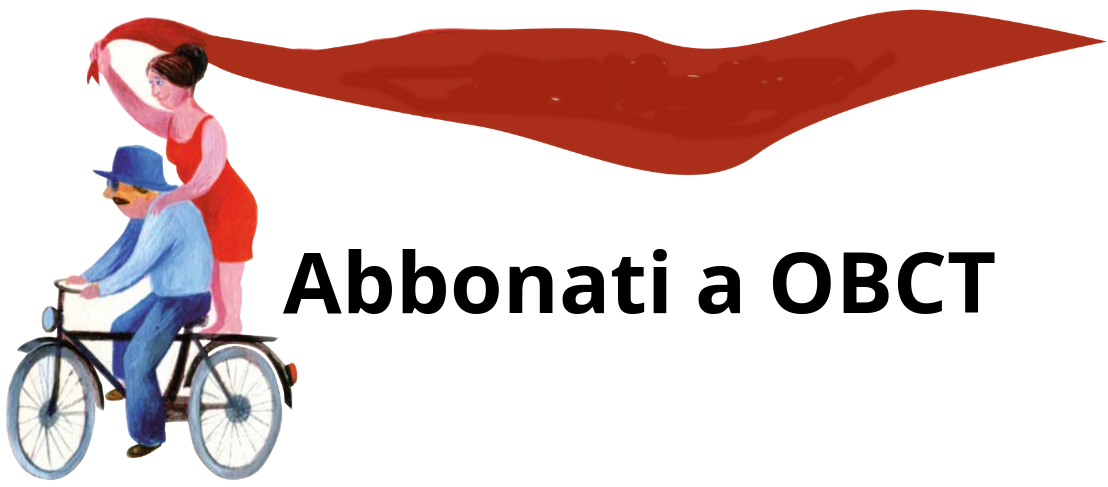Beirut, vista sui quartieri armeni - foto di Paolo Martino
Guardia del corpo di Arafat, poi protagonista della lotta armata armena e infine per 10 anni in un carcere siriano. "Quando sono uscito tutto era cambiato, l'Urss non esisteva più". L'incontro, nel quartiere armeno di Beirut, con Sarop. La seconda puntata del reportage "Dal Caucaso a Beirut"
Dawra si sveglia mentre la notte scivola in mare, inseguita da uno strascico di nebbia. Assonnati sui marciapiedi, manovali siriani partecipano alla quotidiana lotteria del lavoro a giornata. Dawra, “la rotatoria”, epicentro da cui ogni viaggio origina e muore. A nord-est Junie, roccaforte maronita a guardia di Tripoli e della Siria; a ovest l'autostrada, aorta che si strozza nell'ingorgo di Piazza dei Martiri; a sud-est la Montagna, rifugio del mosaico di minoranze che nei secoli hanno popolato il Libano. Ma tutto intorno, fino a lambire i marciapiedi della rotonda, è Burj Hammoud, il quartiere di Beirut in cui si annida l'anima della minoranza armena, giunta qui un secolo fa dopo un viaggio senza ritorno.
Proverbio libanese"Se pensi di aver capito il Libano
è perché te lo hanno spiegato male"
La porta della fabbrica di Rafi, tra i vicoli di Burj Hammoud, incornicia la sagoma di Sarop. I due vecchi amici si concedono un lungo abbraccio su un sottofondo di macchine da cucire, presse, torni e martelli. “Da quando lo conosco Sarop è sempre di fretta. E quando parte, non si sa mai quando torna. Una volta, negli anni '70”, sorride Rafi, “venne a salutarmi per un viaggio di pochi giorni. Lo rividi dopo dieci anni”. Da settimane Rafi lavora per organizzare l'incontro con Sarop. Il momento dei saluti e del tè mi da modo di ripassare i ricordi e organizzare le idee.
All'alba degli anni '70 il Libano era già una polveriera: combattenti palestinesi fuoriusciti dalla Giordania dopo il Settembre nero si trasferivano in territorio libanese. La società nascondeva a stento la tensione, distratta solo dal boom economico e dalla voglia di normalità. In questo clima la comunità armena, arrivata alla terza generazione e forte di trecentomila membri, andava a sua volta maturando istanze politiche, prima fra tutte la richiesta di riconoscimento da parte della comunità internazionale del genocidio subito per mano del governo ottomano sessant'anni prima.
L'incontro con i movimenti armati palestinesi fece da catalizzatore. Il 14 ottobre del '74 Yasser Arafat teneva all'Onu il suo primo solenne discorso con la fondina della pistola attaccata alla cintura: grazie alla lotta armata, la questione palestinese entrava nell'agenda mondiale. Per alcuni armeni la strada per ottenere altrettanta visibilità era tracciata. A mezzogiorno del 22 ottobre 1975 venne ucciso a Vienna l'ambasciatore turco Danis Tunaligil. L'omicidio, rivendicato dall'Esercito Segreto Armeno per la Liberazione dell'Armenia, aprì un decennio in cui personale diplomatico di Ankara, linee aeree turche, sedi di rappresentanza della Turchia e dei suoi alleati vennero ripetutamente sottoposti ad attacchi armati. Le operazioni, che causarono vittime in Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Grecia, USA, Iran e Turchia, venivano organizzate a Beirut, precipitata intanto nel vortice della guerra civile.
“Perché hai scelto la lotta armata?” Nell'ufficio di Rafi il tempo scorre rapido, e non c'è modo di girare intorno all'argomento. “Come hai detto di chiamarti?” Sarop risponde con una domanda. “Paolo”, mi guarda fisso. “Sai Paolo, ne ho visti tanti come te in quegli anni, arrivare a Beirut con matita e taccuino per intervistare, studiare, capire la guerra. Dopo qualche settimana li ritrovavo in giro con un mitra in spalla e un nome di battaglia, arruolati in questa o in quella milizia.” Poi una pausa. “La guerra parla una sola lingua, per sopravvivere devi impararla.” Uomo di mezz'età, Sarop ha il timbro della voce e lo sguardo di chi ha fiducia piena in se stesso.
“E cosa ha dato origine alla vostra lotta armata?” Sul suo volto compare un sorriso malinconico. “Senza la rivoluzione palestinese, nulla sarebbe mai accaduto. Il nome stesso che io porto mi fu dato da Yasser Arafat, che un giorno mi disse: "Se noi palestinesi combattiamo è per non essere dimenticati dalla storia come voi armeni". Così capii che anche noi dovevamo armarci". Per alcuni anni Sarop militò nella guardia personale di Arafat, fin quando il leader palestinese fu costretto dall'occupazione israeliana a fuggire dal Libano. Poco dopo il mondo assistette ai massacri nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila ad opera delle milizie cristiane falangiste, che spesso avevano rivolto le loro armi anche contro gli armeni.
“Nel settembre del '79 quasi duecento armeni furono allineati davanti a un muro e fucilati. I falangisti non tolleravano che vi fossero in questo paese dei cristiani che non ubbidivano ai loro ordini”. Solo tre anni prima, appena fuori Burj Hammoud, quattromila palestinesi venivano trucidati nell'assedio del campo profughi di Tall Zatar e nel massacro di Karantina. Fiumi di sangue lambivano il perimetro del quartiere degli armeni. “Ma i nostri morti furono vendicati e se il loro numero non fu troppo alto lo si deve soprattutto alle nostre organizzazioni armate segrete”.
Sarop fu testimone e protagonista della storia soltanto fino al 1980. Subì a Parigi un attentato che lo gambizzò e venne trasferito per curarsi in Romania. Qui, all'ombra del padrino sovietico, agenti siriani lo avvicinarono per ottenere la sua collaborazione, dati gli ingenti interessi che Damasco esercitava sul Libano. Il rifiuto sancì la sua condanna. “Ho passato dieci anni in un carcere siriano, e quando sono uscito niente era più uguale a prima. L'Urss non esisteva più, l'Armenia era un paese libero, la guerra in Libano era finita. Nei campi palestinesi i ritratti di Marx e Lenin erano stati sostituiti dai versi del Corano. E la rivoluzione era morta”.
“Pensi ancora che la scelta di uccidere personale diplomatico turco fosse giustificata?”. Sarop controlla l'orologio. “Fino al 1915 la mia famiglia viveva in una grande fattoria. Mio nonno, sopravvivendo al genocidio, mangiò sabbia nel deserto iracheno durante la deportazione prima di ritrovarsi in una baracca sudicia a Beirut”. Il tono accelera: “Ma nessuno allora ha pianto per quelle tragedie e certo io non piango oggi la morte dei governativi turchi. La nostra lotta armata comunque ormai è finita, giusta o sbagliata che fosse e abbiamo ottenuto molto. Tanti paesi hanno già riconosciuto il genocidio ed altri lo riconosceranno. Tuttavia - Sarop è già in piedi - le anime delle centinaia di migliaia di vittime del genocidio marciano ancora incolonnate sugli altopiani anatolici, in attesa di giustizia. Io ho giurato che non calpesterò mai quelle terre finché saranno occupate dai turchi, ma tu sei libero di andarci. Vai, le troverai ancora lì”.
Dal mio diario. 6 ottobre
Sarop esce dall'ufficio infastidito dal dover provare la legittimità morale delle operazioni del suo gruppo armato. In guerra, d'altronde, vale il principio per cui il fine giustifica i mezzi. Rispetto alla rivolta in atto in Siria, lui stesso ammette: “Ho un rancore profondo per la dinastia degli Assad, mi deve dieci anni di vita. Ma in questo momento il loro regime è l'unico in grado di proteggere la minoranza armena in Siria e finché non ci saranno alternative è bene che la situazione non si evolva.” Vittime e carnefici si tengono per mano.
Rafi mi riaccompagna a ritroso attraverso le strade di Burj Hammoud. Insegne, cartelli stradali, urla dei mercanti: tutto in lingua armena, quasi a riannodare il filo di continuità tra questa comunità e le sue origini, reciso un secolo fa dalla storia. Intonaci mal imbiancati rivelano le raffiche di proiettili che in vent'anni di guerra civile hanno crivellato il quartiere, nonostante gli armeni avessero fin da principio dichiarato la loro neutralità. “Rafi, anche tu credevi nella lotta armata?” I vicoli si aprono finalmente su Dawra, e Rafi si arresta all'improvviso: “Proprio in questo punto c'era un mercatino in cui si vendevano Kalshnikov e granate. Lungo quella strada,” indica una delle tangenti di Dawra, “mio fratello fu sventrato da una bomba. Davanti ai tavolini di quel bar Sarop fu mitragliato da una macchina in corsa, se la cavò solo grazie al sacrificio della guardia del corpo. Capisci cosa intendeva Sarop dicendo che la guerra parla una lingua sola?”
Nel taxi che si allontana da Dawra, dove oggi la storia è uscita dal racconto e si è fusa col presente, nella mia mente prende a pulsare la sfida che Sarop ha lanciato congedandosi: “Il fantasma del mio popolo vaga ancora nel vento dell'altopiano anatolico. Vai, lo troverai ancora lì.”
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
Commenti
Log in or create a user account to comment.