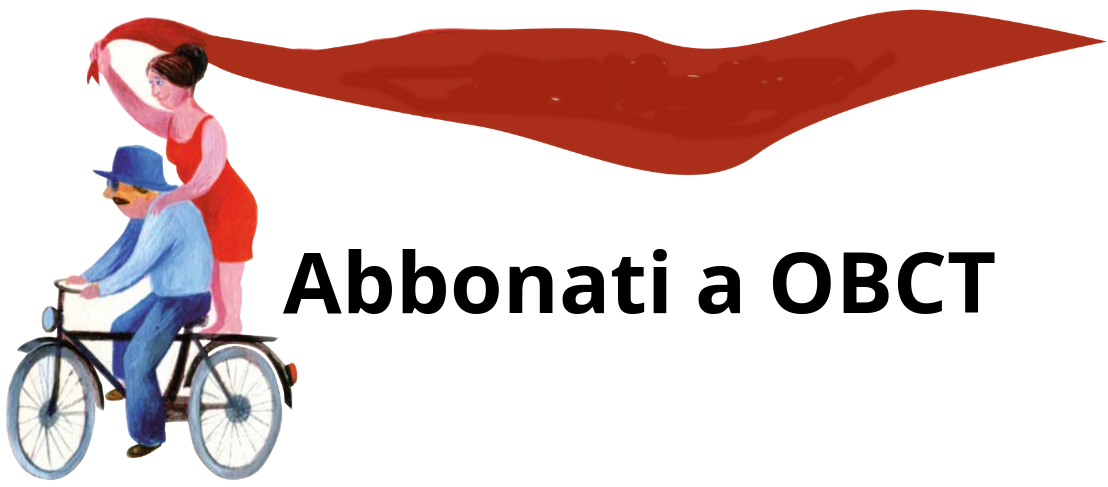Sarajevo (Foto mungosciko, Flickr )
Il fascino di Sarajevo non lascia scampo. Ma la città che ha resistito all'assedio grazie all'amore dei suoi abitanti sta cambiando, e non in meglio. La quarta puntata del reportage di Michele Nardelli
Qualcuno dei miei compagni di viaggio mi chiede perché la grande maggioranza dei cittadini di Sarajevo decise di restare nonostante l'assedio, le granate che piovevano sugli edifici e sulle vie, i cecchini carichi di eroina che si divertivano a giocare con la vita della gente, la mancanza di cibo e di elettricità, i freddi inverni senza la possibilità di riscaldarsi...
Credo che le ragioni siano molteplici. Intanto perché nessuno si sarebbe mai immaginato che una capitale europea potesse essere assediata per quasi quattro anni, perché nessuno riteneva possibile una guerra in Bosnia e tanto meno a Sarajevo, nemmeno quando già si sparava per le strade della città, e infine perché, dopo che la guerra era diventata realtà, pensavano che si sarebbe risolta nel giro di qualche settimana.
A guerra in corso, poi, non era così semplice andarsene. Rimanere era altresì un punto d'orgoglio, per difendere la città dagli assedianti, per non lasciare i propri cari, per non darla vinta ai nemici della città, o anche semplicemente per non lasciare tutto per ritrovarsi in un'anonima periferia del mondo a chiedere l'aiuto peloso di chicchessia.
C'è anche, e forse sopratutto, un'altra ragione: perché gli abitanti di Sarajevo amano la loro città. Se questo, certo, può essere vero per ogni città, lo è un po' di più per la "Gerusalemme dei Balcani". E' sufficiente ascoltare le parole di Kanita, per comprendere quale effetto profondo provi verso la sua città che pure le ha riservato un destino non sempre facile. Come quando, all'inizio della guerra, la scheggia di una granata venne a farle visita in casa portandole via il compagno della sua vita.
Agli occhi di chi già ha imparato a conoscerla, come per chi è qui per la prima volta, il fascino di Sarajevo non lascia scampo. Eppure è cambiata e sta cambiando, purtroppo non in meglio. La città che ha saputo resistere per millequattrocento giorni ai bombardamenti e ai cecchini, oggi ha paura. Quel che segna la città è l'onda lunga della guerra, ovvero della criminalità organizzata, della piccola malavita, ma anche dell'imbarbarimento delle relazioni fra le persone. Di una povertà crescente a fronte della ricchezza dei luoghi, degli anziani che non hanno di che vivere, stridente con il lusso di chi è arricchito nella guerra come nel dopoguerra.
Di questa stessa fatica del vivere a Sarajevo mi parlava qualche mese fa Eugenio, dopo aver fatto l'esperienza di qualche mese proprio nella capitale bosniaca per le attività di "Viaggiare i Balcani". Quasi ci fosse una grande distanza fra la città pubblica degli eventi importanti e una quotidianità all'insegna del "si salvi chi può".
I segni della guerra sono pressoché scomparsi, ma questo non significa che le ferite si siano rimarginate. La guerra è dentro ciascuno, il conflitto non elaborato s'intreccia con l'assenza di futuro. Sensazione che avvertiamo anche noi, nelle poche ore che trascorriamo in questa bella città nel cuore di un'Europa che non l'ha saputa comprendere e che continua a tenerla lontana. Proliferano le banche, i centri commerciali, i grandi palazzi di vetro... lo scheletro del nuovo hotel Hilton incombe proprio in prossimità della città asburgica. E' l'omologazione della modernità, mentre le piccole cose di qualità vengono soffocate dalla ricerca del business. L'omologazione degli affari accomuna le diverse entità e l'orizzonte di una sfera politica che per mantenere il consenso ha bisogno di spiegare la povertà, la burocrazia, il malaffare con le lenti del nazionalismo, riversando le responsabilità sull'altro, come già in guerra un comodo nemico.
Ecco perché il lavoro di elaborazione del conflitto è ineludibile. Dovrebbero capirlo la cooperazione internazionale, le Ong e la cosiddetta società civile, ma questo non avviene. Più semplice lavorare sugli aiuti, non servono granché ma l'effetto sgocciolamento tiene in vita una parte dell'economia informale. Qui, come altrove, occorre un cambio di pensiero.
Mi vengono in mente le donne che sono venute a Trento nei giorni scorsi a parlare della “primavera araba”. E di una paura che hanno saputo vincere. Ponevano, quale condizione per tenere viva la primavera, esattamente lo stesso problema. Che ci sia bisogno di una primavera balcanica?
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
Commenti
Log in or create a user account to comment.