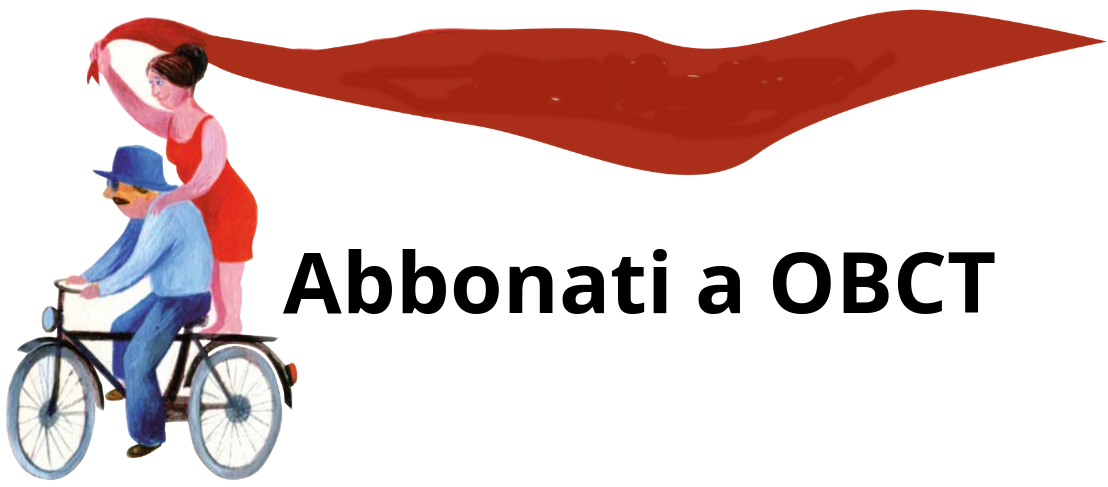18 cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina: il libro della nostra corrispondente Azra Nuhefendić, in uscita per Spartaco edizioni, raccoglie un filo di sentimenti e ricordi che si snoda lungo 20 anni di storia europea. La recensione di Alessio Altichieri
Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul blog del Corriere della Sera Chelsea mia, con il titolo La guerra è orrenda, ma ci educa: prima lezione, dire no alla vendetta
Nel libro «Le stelle che stanno giù», memorie private di una tragedia storica, la fine della Jugoslavia che culminò con gli orrori della Bosnia, Azra Nuhefendić scrive che perfino il più profondo dolore diminuisce nel tempo, perché «con il passare degli anni siamo in grado di accettare anche le perdite che ci parevano inammissibili». Ciò che non passa mai, che neppure il tempo lenisce, è invece «il sentimento provocato dall’ingiustizia»: è l’offesa, l’umiliazione, lo stupro fisico e morale di chi ha subito un abuso, un crimine e deve inghiottire, oltre al patimento che è una cicatrice dell’animo, anche l’affronto di vedere i briganti, gli assassini, andare a piede libero, a testa alta, impuniti.
«In Bosnia sono state identificate circa diciassettemila persone che hanno partecipato ai crimini di guerra». Certo, qualcuno è finito davanti al tribunale dell’Aja, benché ancora sfugga Ratko Mladić, il boia di Srebrenica. E gli altri? «Alcuni si nascondono, alcuni sono scappati in altri Paesi, ma per la maggior parte i responsabili di quei crimini sono ancora liberi», compresi i colpevoli di genocidio: «Vivono accanto alle vittime, come se nulla fosse accaduto». Come si può, quindi, dimenticare?
Ricordare
Azra Nuhefendić non dimentica, e scrive. Le sue memorie iniziano su un treno, quello che da bambina la portava dalla città natale, Sarajevo, alla colonia estiva di Bijela, sull’Adriatico, dove il regime comunista di Tito mandava in vacanza i figli del sistema multi-nazionale, multi-religioso, multi-etnico della Jugoslavia, e si concludono su un altro treno, l’ultimo treno da Belgrado a Sarajevo, in un viaggio da incubo ai confini della notte, quando per la Bosnia, sotto i colpi del nazionalismo serbo di Slobodan Milošević, s’aprì l’inferno. Una testimonianza, questa, che le ha meritato il premio «Writing for Central and Eastern Europe», accolto l’autunno scorso a Vienna con un discorso sul tema dell’«altro», del diverso, pubblicato sul sito dell’Osservatorio Balcani e Caucaso, di cui è corrispondente. Questa spiegazione per dire che Nuhefendić è giornalista, e che era una giornalista così brava, negli anni ’80, da essere trasferita dalla tv di Sarajevo a quella di Belgrado, capitale della Serbia e della Jugoslavia, dove avrebbe compiuto memorabili reportage, come quello sui minatori del Kosovo in sciopero.
Ma aveva la colpa d’essere diversa: musulmana. Ciò naturalmente non ha nulla a che vedere con la religione, perché Nuhefendić è agnostica, né con l’ideologia, perché ha creduto al di là del credibile alla «fratellanza» che era il dogma di Tito. Ma ha molto a che fare con la nazionalità, perché in Bosnia essere musulmano voleva dire non essere serbo, né croato: soltanto un’etichetta, ma fatale, per qualcuno spregiativamente chiamato «balija».
Ovviamente Nuhefendić pagò di suo: perse il lavoro, con le minacce fu costretta all’esilio, e tuttora vive, alla ricerca d’impossibili radici, a Trieste. Ma nulla fu il prezzo suo (nessun vittimismo in lei, piuttosto disillusa ironia) rispetto a quanto pagarono coloro che rimasero. Molti non possono più raccontare: «Prima della guerra le colline intorno a Sarajevo erano coperte di prati verdi e di boschi. La guerra ha cambiato il paesaggio. Oggi le alture sono nude, la città è circondata da cimiteri. Guardando Sarajevo dai punti dominanti, si notano molti brandelli bianchi, sembrano pecore che pascolano. Per chi non sa, potrebbe essere anche un paesaggio pastorale. Il bianco delle lapidi abbaglia lo sguardo».
Ogni giorno, dall’aprile 1992 al febbraio 1996, i cecchini che assediavano Sarajevo uccisero decine di persone, diecimila in totale, di cui 1.600 bambini. E non c’era spazio per tutti quei morti: parchi, campi di calcio, aiuole, ogni spazio verde diventò cimitero: «Un’intera generazione di ventenni di Sarajevo è sepolta nei luoghi dove una volta si dondolavano sull’altalena, passeggiavano con la fidanzatina, o sognavano un futuro da calciatore». E si creò un assurdo mercato: «Quando mia sorella Esa morì, cercammo disperatamente un posto in qualsiasi cimitero. Per una tomba a Turbe-Bistrik, sulle falde del monte Trebević, pagammo mille euro, nell’epoca in cui un appartamento costava seimila euro. Non sapevo nemmeno che fosse un cimitero: ci pascolavano le pecore. Oggi è strapieno».
Penelope
Chissà, forse andò peggio a chi riuscì a sopravvivere. A chi ebbe la sventura di abitare in una zona presa dai serbi, come Lukavica, appena fuori Sarajevo: lì viveva Mila, serba, col marito, un ingegnere musulmano, e due figlie. Un giorno i serbi vengono a prendere il «balija», per farlo fuori. Lui è rassegnato, Mila no: vestita da maschiaccio, stivali di gomma, li affronta: «Non portate via il padre delle mie figlie: prendete me», dice ai banditi che, usi allo stupro come bottino di guerra, scoppiano a ridere. Alla fine, fa un patto: per aver salva la vita, il marito deve andare ogni giorno al fronte, e sparare sui musulmani, «i suoi», assediati lì sotto. La guerra è poi finita, l’uomo s’è salvato, ma ha perso l’uso della parola, il trauma (paura, vergogna?) l’ha torturato per anni. E Mila, la donna eroica che ha osato sfidare le canaglie, ora ha il terrore di uscire da casa. Non tutti avevano un talismano come Nadja, Penelope bosniaca, che ricamava un pezzo di stoffa, insignificante, per aspettare la fine dell’assedio: era brutto se bombardavano, certo, ed era peggio se i cecchini sparavano. Era al piano di sotto, a prendere una tisana dai vicini, quando un colpo entrò dalla finestra: «Zaaac, e il suo vicino Ante era morto, afflosciato per terra, in silenzio». E fu peggio ancora quando il suo stabile, in prima linea, divenne terreno di caccia dei serbi: Nadja li sentiva salire le scale, entrare negli appartamenti, capiva in quali stanze rovistavano nei cassetti già depredati da altri e, se non trovavano niente, delusi e arrabbiati, spaccavano i mobili. Quando poi un calcio spalancava la sua porta, inspiegabilmente, Nadja si calmava. Ma come comportarsi? Reagire, essere ostile, era impensabile. Usare cortesia era peggio: la guardavano con disprezzo, sapendosi padroni. Se mostrava umiltà, s’adiravano. Se faceva l’indifferente, continuando a ricamare, si offendevano, perché esigevano rispetto e attenzione. Con l’esperienza, aveva imparato a mettersi da parte, e parlare solo per rispondere alle domande. Prima o poi se ne andavano, e Nadja ha potuto tessere il suo ricamo fino alla fine dell’assedio, da superstite.
Restare umani
Sono molte le storie di crudeltà inumana e ognuna, come avrebbe capito Tolstoj, ha una propria disumanità. Ma ciò che ciascuna lascia, come scrive Nuhefendić, è il sentimento provocato dall’ingiustizia. Sarajevo è oggi una città di targhe, di lapidi, dove ogni casa, ogni ufficio, le Poste, una scuola, ha la sua testimonianza di vittime dell’assedio, uccise dai cecchini o dalle bombe. All’Università, alla facoltà di Filosofia, ci sono quattro colonne piene di nomi, studenti che, come Azra Nuhefendić, avevano seguito le lezioni di Milorad Ekmečić, noto storico, «autorità non solo scientifica, ma anche morale e umana». Così lei non poteva credere alle parole del professore che, all’inizio della guerra scatenata per fare «la grande Serbia», aveva detto che «cento o duecentomila morti non sono niente, considerato l’evento storico».
Come poteva «un educato, intelligente e illustre professore» aver detto un abominio del genere? Naturalmente l’aveva detto, e presto riparò a Belgrado, tra i serbi, dove rilasciava interviste, firmava petizioni, giustificava la guerra. Lei lo incontrò per caso, proprio a Belgrado, quando ancora non sapeva se i suoi genitori, sotto le bombe di Sarajevo, si sarebbero salvati: il professore e l’ex allieva si riconobbero, non si salutarono. Quel giorno, col sentimento dell’ingiustizia che le montava in cuore, meditò vendetta, proprio sul professore. Poi lo rivide ancora, a guerra finita, mentre passeggiava in un parco, impunito e indifferente. Seduta su una panchina, a mente lucida, ripensò a quel desiderio di vendetta e alle minacce che, tra sé, aveva pronunciato. «Mi vennero i brividi per la mostruosità che scoprii, all’improvviso, dentro di me». Era il «germoglio della futura vendetta», frutto velenoso della guerra, eredità maligna del male, che Azra Nuhefendić c’insegna a inghiottire, se vogliamo restare umani.
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
Commenti
Log in or create a user account to comment.