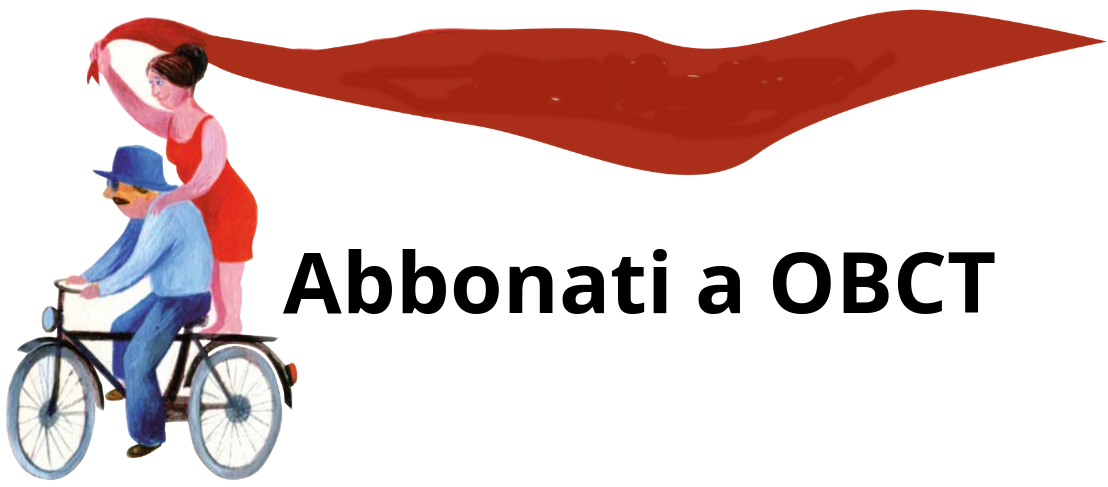Radovan Karadžić (Hulton/wikicommons)
Ieri il MICT (Meccanismo residuale per i tribunali penali internazionali) ha condannato in appello all'ergastolo l'ex leader dei serbo bosniaci durante la guerra degli anni '90. Mentre Karadžić sconterà la pena in uno stato per ora sconosciuto, le sue idee purtroppo continuano a circolare
Nel processo di appello, la difesa di Radovan Karadžić sostenne a un certo punto che il proprio assistito, essendo “un poeta e uno psichiatra, privo di formazione militare, non preparato per una guerra”, non poteva che essere innocente. La sentenza in via definitiva di ieri consegna al diritto e alla storia la verità opposta, stabilendo che Karadžić, il “buon vicino” , il “bravo collega” che faceva gli auguri di Bajram agli amici musulmani, il “camaleonte dai modi che sarebbero comici, se le sue parole e azioni non avessero marcato il destino di tante vite umane”, ebbe un ruolo decisivo nella guerra del 1992-95 in Bosnia Erzegovina.
L’ex-presidente della Republika Srpska pianificava le operazioni, dava gli ordini, riceveva le informazioni sulle quattro “imprese criminali” per cui è stato condannato all’ergastolo: il genocidio di Srebrenica - ovvero l’eliminazione fisica della popolazione musulmana nella cittadina attraverso l’uccisione degli uomini e l’evacuazione forzata di donne e bambini -; il terrore contro i civili di Sarajevo attraverso una campagna di bombardamenti e di cecchini; la pulizia etnica contro la popolazione non-serba in diverse municipalità dell’intera Bosnia Erzegovina; la presa in ostaggio del personale ONU. Queste sono le tesi della sentenza di primo grado del Tribunale per l’ex-Jugoslavia del 2016, che ieri il MICT (Meccanismo residuale per i tribunali penali internazionali) ha confermato interamente.
La Corte del MICT ha dunque innalzato la pena all’ergastolo, con la motivazione che “la responsabilità di Karadžić per i più gravi crimini mai attribuiti a una singola persona all’ICTY” non poteva permettere una condanna più mite. La sentenza cita i quattro imputati che hanno ottenuto l’ergastolo per avere commesso “frazioni” dell’insieme di crimini di cui è stato giudicato responsabile Karadžić: gli ufficiali serbo-bosniaci Tolimir, Popović, Beara e Galić – tutti subordinati a Karadžić che, in qualità di presidente, era anche il comandante supremo della Republika Srpska. Sarebbe stato quindi “incongruente”, prosegue la sentenza, riconoscere a Karadžić una pena inferiore, così come fece la Corte di primo grado nel 2016, con una condanna a 40 anni che fu molto criticata dalle associazioni di vittime e dalla società civile.
La scelta del MICT va letta anche in termini di bilancio della giustizia internazionale. Alla chiusura definitiva delle cause sull’ex-Jugoslavia mancano solo due sentenze di appello, quella di Ratko Mladić e quella a carico di Stanišić e Simatović. Nelle parole della sentenza si intuisce la volontà di salvare l’eredità degli organi internazionali e stabilire una conclusione coerente, in un percorso giurisprudenziale che ha subito diversi sbandamenti: si pensi ai casi del croato Gotovina, del kosovaro Haradinaj, dei serbi Perišić e Šešelj e del bosniaco musulmano Orić, tutti assolti o condannati con pene ridotte, che hanno causato pesanti attacchi alla credibilità del Tribunale Internazionale per l’ex-Jugoslavia.
Prove
La sentenza è forse l’ultima occasione di rilievo per ridare centralità ai documenti, alle azioni compiute, alle prove inconfutabili prima che diventino uso esclusivo di storici e addetti ai lavori. È dunque utile ripercorrere il testo della sentenza e i materiali citati. Tra questi ci sono i “Sei obiettivi strategici” (Šest strateških ciljeva) presentati da Karadžić al parlamento serbo-bosniaco il 12 maggio 1992, che prevedevano la separazione di Sarajevo in una città serba e una musulmana, e la realizzazione di “corridoi territoriali” disseminati in tutta la Bosnia Erzegovina (Semberija-Krajina, Drina, Una-Neretva, accesso al mare), il tutto da realizzarsi con un’occupazione militare e l’espulsione della popolazione non-serba.
C’è la Direttiva 7, un documento riservato firmato da Karadžić l’8 marzo 1995 che ordina al Battaglione Drina di “creare una situazione insopportabile di totale insicurezza, che non lasci speranza di sopravvivenza o vita per gli abitanti di Srebrenica e Žepa”. Ci sono le trascrizioni dei contatti tra Karadžić e il personale militare operante nei trasferimenti di centinaia di prigionieri - poi uccisi in massa - tra Srebrenica, Kravica e Zvornik nel luglio ‘95 e nei bombardamenti sul centro di Sarajevo nel maggio 1992, che smentiscono la tesi difensiva secondo cui il presidente non era al corrente delle azioni sul terreno.
Può sembrare paradossale, ma di questi documenti si parla e si parlerà sempre meno. È vero che in Bosnia Erzegovina il passato è un peso perfino troppo opprimente nella vita quotidiana. Ma lo è in termini di miti, di proiezioni, di bolle mediatiche, delle sofferenze intime del dopo e dell’oggi. Le uniche prove tangibili sono quelle dei dolori familiari, non quelle che possano attribuire una responsabilità chiara e mutualmente riconosciuta dei crimini. Chi è vicino alle vittime accusa – comprensibilmente - stanchezza e una ritraumatizzazione continua. Chi solidarizza con i condannati sviluppa tecniche di revisionismo sempre più sfrontate.
Reazioni e memorie contrapposte
Se il verdetto del 2016 scontentò un po’ tutti, le reazioni di queste ore sono state decisamente più polarizzate. Rappresentanti politici di parte civica o bosgnacca hanno espresso generale soddisfazione per la condanna all’ergastolo. Associazioni, sopravvissuti e familiari delle vittime di Srebrenica, che come nei precedenti casi hanno assistito al verdetto nella sala tv del Memoriale di Potočari, hanno accolto l’annuncio della condanna con applausi e abbracci.
Anche in questi settori, rimane però un elemento di delusione. Il MICT ha infatti rigettato la richiesta dell’accusa di condannare Karadžić per genocidio non solo a Srebrenica, ma anche in altre sette municipalità (Ključ, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica, Foča, Zvornik, Bratunac). Così come avvenne nella sentenza 2016, sono stati riconosciuti i crimini su base etnica in queste municipalità, ma non l’”intento genocidario”. Il riconoscimento di Srebrenica come evento unico genera alcune perplessità, perché crea confusione alla lettura storica del conflitto in Bosnia Erzegovina (“Un genocidio come ‘incidente singolo’ non è avvenuto in nessun genocidio conosciuto. […] Limitare il genocidio a un singolo evento nel 1995 contrasta con i fatti accertati“, sostiene Eric Gordy ), oltre a creare una scomoda gerarchia di vittime e riconoscimenti. Era però un esito previsto dagli analisti, per l’assenza di nuovi elementi e l’attesa indisponibilità del MICT ad aprire un nuovo criterio giurisprudenziale.
Hanno commentato la sentenza con favore anche la presidente croata Kolinda Grabar Kitarović e il premier di Zagabria Plenković. L’unico politico bosniaco a non rilasciare alcun commento ieri è stato Dragan Čović, leader dell’HDZ BiH (nazionalisti croati di Bosnia). È un silenzio che stride terribilmente con le persecuzioni che migliaia di croati della Krajina, della Posavina e di Sarajevo hanno subito per via del disegno di Karadžić. Ma è perfettamente coerente con l’attuale posizione politica di Čović, fedele alleato dei nazionalisti serbo-bosniaci che in questo modo non ha messo in imbarazzo. Čović si comportò nello stesso modo dopo la condanna di Ratko Mladić, nel novembre 2017. È un esempio paradigmatico di come gli interessi dell’etno-partito-crazia bosniaca contino più di ogni altra cosa, persino più delle memorie e delle sofferenze del proprio gruppo nazionale.
In senso del tutto opposto si sono espressi gli esponenti politici, istituzionali e media di parte serbo-bosniaca, tutti concordi nel criticare la sentenza, senza alcuna distinzione maggioranza-opposizione. Milorad Dodik, membro della presidenza collettiva bosniaca, l’ha definita “cinica e arrogante”. Su RTRS, il canale TV della Republika Srpska, appena trasmessa la sentenza il dibattito tra gli ospiti in studio si è trasformato in una preoccupata riflessione geopolitica sulle ripercussioni per la Republika Srpska e per la Russia, nonché per i finanziamenti che l’Arabia Saudita avrebbe offerto al Tribunale dell’Aja, garantendosi così un potere d’ingerenza. Nel servizio di un altro canale TV bosniaco, il sarajevese N1, tutti gli intervistati in strada a Sarajevo Est e a Banja Luka auguravano la liberazione di Karadžić con espressioni quasi identiche tra loro, e a loro volta identiche a quelle dei politici serbo-bosniaci: “Lui ci ha difeso”, “È uno di noi”, “la satanizzazione del nostro popolo”, “il tribunale politico”. Può darsi che alcuni di questi commenti siano segnale di inerzia civile, di conformismo, più che di supporto consapevole. Resta che il livello di polarizzazione della memoria e di codificazione del discorso cresce a mano a mano che aumenta la distanza temporale dagli eventi.
Mobilitazioni ed emulazioni
Radovan Karadžić e Ratko Mladić hanno perso la loro battaglia personale. Ma la mobilitazione a favore della loro reputazione, e della loro visione del mondo, si rafforza nel loro paese d’origine. Si apre persino a nuovi spazi, si internazionalizza grazie all’esasperazione nativista che sta marcando questa epoca. È noto che Brenton Tarrant, il terrorista neozelandese che ha ucciso 50 persone nell’attacco alla moschea di Christchurch, ha ascoltato una canzone in onore di Karadžić mentre guidava verso il luogo del massacro, lo scorso 15 marzo. (Meno noto è che Tarrant nell’estate 2016 ha visitato i Balcani, passando in Bosnia Erzegovina via Trebinje e poi in Croazia, come hanno accertato le autorità dei due paesi).
In questi giorni, diversi osservatori si sono interrogati sulla capacità evocativa dei miti nazionalisti balcanici e sui loro nessi con il suprematismo razziale e l’odio religioso. Durante il processo, Radovan Karadžić aveva rilanciato il principio della “guerra santa e giusta” contro gli ottomani-musulmani , rievocando l’immaginario dei Balcani come barriera cristiano-europea che oggi si fa sempre più mainstream, alla luce delle rotte migratorie, dei cambiamenti geopolitici e della crisi delle idee socialiste e liberali in UE.
In una lunga riflessione su twitter, il giornalista Refik Hodžić ha analizzato la violenta disumanizzazione con cui Karadžić ha mobilitato i suoi sostenitori contro i propri vicini musulmani, etichettati ai tempi della pulizia etnica come “generazioni di occupanti”, “traditori che vendettero la fede” “parassiti da rimuovere”. In conclusione, Hodžić si chiede “come umanizzare ciò che è stato disumanizzato”, “come ristabilire una comunicazione” nelle società post-jugoslave, come evitare l’eredità nociva della segregazione. Sempre partendo dal caso di Tarrant-Karadžić lo storico bosniaco Edin Hajdarpasić sul Washington Post ha esaminato le radici transnazionali ed emulative dell’estremismo di destra. È dagli anni ’30, scrive Hajdarpasić, che l’ultra-nazionalismo europeo e americano ha “imparato l’uno dall’altro”, sognando un mondo di nazioni pure allo stesso tempo in cui manteneva una dimensione ispiratrice internazionale. E lo stesso sta avvenendo oggi, con strumenti molto più veloci.
Mentre le sue idee circolano Radovan Karadžić, il "buon vicino", sconterà l’ergastolo in uno stato ancora sconosciuto, che sarà indicato tra i paesi aderenti alla convenzione ICTY. Una destinazione ignota ora tocca anche lui, come è toccata ai circa due milioni di profughi costretti ad abbandonare le case per la pulizia etnica degli anni Novanta, come sta toccando alle migliaia di emigrati che lasciano la Bosnia Erzegovina ogni anno, in cerca di un futuro più prospero ed umano.
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
blog comments powered by