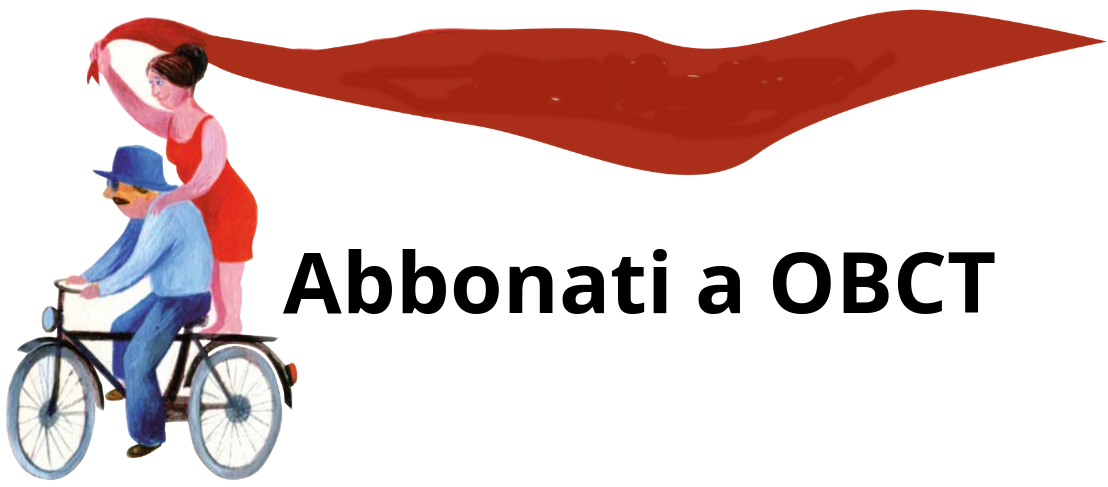L'incontro con Vartuhi e con il destino che la separò dalla sorella nel 1946. Vive a Musa Dagh, in Armenia, dove un enorme falco appollaiato ricorda i combattenti armeni che nel 1915 si opposero alle truppe ottomane. La quinta puntata del reportage "Dal Caucaso a Beirut"
Vartuhi fissa il ritratto di Angel, affondando lo sguardo nei segni che il tempo ha inciso su quel volto. Sessantacinque anni di silenzio si infrangono nell'umanità del più spontaneo pensiero fraterno: “Dio la benedica, i suoi occhi sono rimasti gli stessi”. La donna poggia la foto sul tavolo senza perderla di vista, e rivolgendosi al marito, che osserva in disparte, lo invita: “Guarda, questa è mia sorella”.
Armenia. Un mastodontico rapace in mattoni rossi presidia l'autostrada tra la capitale Yerevan e la città sacra di Echmiadzin. Il bus accosta davanti a un cartello che indica il nome del villaggio adiacente. Non serve saper leggere l'armeno per capire cosa c'è scritto: l'enorme falco appollaiato è il simbolo dei combattenti di Musa Dagh, gli armeni che nel 1915 si opposero alle truppe ottomane arrivate per deportarli. Questo villaggio e il monumento che lo sovrasta rappresentano la continuità storica di quella comunità umana: fuggiti una prima volta in Egitto nel 1915, rientrati a casa nel 1919, trasferiti in Libano nel 1939, parzialmente rimpatriati nell'Armenia sovietica nel 1946. L'autobus riparte abbandonando il luogo al sibilo del vento: dallo zaino tiro fuori il ritratto che mi porto dietro dal Libano e mi addentro nei viali sterrati, fiancheggiati da case basse.
Hayk Demoyan, direttore del memoriale del genocidio armeno di YerevanIl genocidio non è storia. E' presente
“Angel ha dieci anni più di me, e aveva già un figlio quando i nostri genitori decisero di partire dal Libano per venire qui, in Armenia. Ci dividemmo: noi siamo partiti per primi, Angel invece rimase ad Anjar, in attesa di un nostro segnale. Avevo nove anni”. Le mani callose di Vartuhi continuano a stringere la foto di Angel, la sorella che non vede dal 1946. In tutta la vita Vartuhi non ha fatto altro che la contadina in questo villaggio, cittadina dello stato più povero del Caucaso. “Ma quel segnale non fu mai inviato. Nostro padre impedì che Angel e la sua famiglia ci raggiungessero. Qui trovammo fame, freddo e lo spettro della Siberia.”
Sul tavolo, il ritratto della sorella perduta calamita i pensieri, evocando ricordi lontani come un Graal proveniente da un'altra epoca. “Partimmo da Beirut a bordo della Pobeda verso il Mar Nero, poi in treno da Batumi fino a Yerevan. Avevamo grandi sogni, finalmente una vera patria. Arrivavamo
incoraggiati dai giornali, dalla propaganda, dalla speranza”. Il pomeriggio scivola veloce sui racconti di Vartuhi, mentre il sole si affretta a lasciare il posto a una notte glaciale, rendendo ancora più drastica la distanza dal Libano. Prima che sia buio estraggo la macchina fotografica, mentre l'anziana si sistema per un ritratto. Nello sguardo, la stessa luce che qualche giorno fa illuminava gli occhi della sorella maggiore, sul volto la stessa severità. “Pensi che Angel riuscirà a riconoscermi?”
Prima di lasciare il villaggio mi addentro nella pancia del rapace, dove un piccolo museo raccoglie cimeli, documenti, memorie dei profughi di Musa Dagh. Nelle teche in compensato si glorifica il sacrificio degli antenati, tentando di trasformare la cicatrice del passato in una storica sfida da tramandare attraverso le generazioni in esilio. Un tagliando prestampato racconta la migrazione di Sarkis Penenian e della sua famiglia, rimasti alla storia grazie all'ingiallita carta d'imbarco sulla Pobeda. “Familiari al seguito: cinque. Porto di partenza: Beirut. Porto di arrivo: Batumi. Emesso a Beirut il 19/9/1946. Firmato: Comitato per il rimpatrio degli armeni di Libano e Siria”. Prezzo, cinquanta lire libanesi: il viaggio di sola andata verso l'ignoto si acquistava a prezzi modici.
Dal mio diario.
Da cosa dipende il destino di un profugo? Dalla nave che prende o che perde, dal consiglio che segue o che ignora. Il campo profughi palestinese in cui vivo si trova a Beirut semplicemente perché nel '48 i rifugiati riuscirono a fuggire su un treno che faceva servizio tra Palestina e Libano appena prima che il tunnel ferroviario tra i due paesi fosse fatto saltare. Così Vartuhi e Angel, le sorelle armene divise solo da un viaggio in nave di pochi giorni nel 1946, hanno attraversato un secolo intero senza mai più incontrarsi. La diaspora è la terra delle circostanze. L'unica patria dei profughi è la memoria, e la guerra è la loro vera madre.
La nebbia che intrappola Yerevan si scioglie già sulle prime rampe che salgono verso lo Tsitsernakaberd, il memoriale del genocidio armeno. Quassù Armenia e diaspora si fondono, ricostituendo simbolicamente l'unità delle due anime del popolo armeno. Una fiamma sulla sommità della collina ricorda il milione e mezzo di vittime, mentre a fondovalle la capitale è coperta da un tappeto bianco di silenzio e nuvole basse.
“Diaspora e genocidio sono due facce della stessa medaglia. Una questione rimanda all'altra”. Hayk Demoyan, direttore del memoriale, mi attende nella semioscurità dei corridoi, dove fotografie e documenti ricostruiscono le tappe della tragedia subita dal popolo armeno un secolo fa. “Riconoscere il genocidio è il passo necessario per dimostrare comprensione per la storia della diaspora”. La politica di stato turca nega che massacri e deportazioni compiute dall'impero ottomano a danno degli armeni avessero scopi genocidari, minando le possibilità di normalizzare le relazioni tra i due paesi.
“Nel 2009 siamo stati ad un passo da un'intesa, ma almeno per ora la firma dei protocolli non ha portato a nulla”. Gli accordi a cui si riferisce Demoyan prevedevano la riapertura della frontiera tra Armenia e Turchia, chiusa dal 1993, riducendo l'isolamento del piccolo stato caucasico. Oltre alla questione del confine occidentale, infatti, Yerevan è alle prese con un ventennale conflitto sul Nagorno - Karabakh con il vicino orientale, l'Azerbaijan. “I tempi non erano ancora maturi, ma il tempo gioca a nostro favore. Nel giro di qualche anno potremo raccogliere i frutti della nostra politica di apertura”.
Dalle vetrate panoramiche della hall il Monte Ararat, emblema e simbolo della saga armena, riempie il cielo man mano che la foschia lascia il posto a un cielo terso e gelido. Il gigante bianco giace oltre il confine, in territorio turco, assegnato dalla storia alla sovranità dell'ingombrante vicino. “Ma l'Armenia non ha pretese territoriali, l'abbiamo ribadito in tutte le sedi internazionali”. Dopo un anno trascorso a contatto con la diaspora libanese, l'approccio di Demoyan alle relazioni con la Turchia suona molto pragmatico, lontano dalla retorica agguerrita e dai sogni di rivalsa che serpeggiano tra i quartieri armeni di Beirut. “La diaspora ha pagato il prezzo più alto della follia genocida ottomana, è per questo che ha interiorizzato un approccio emotivo. Come cittadini di questo paese, però, noi dobbiamo guardare alla questione anche con occhio realistico”.
Il breve giro di sole si chiude dietro il sipario dell'Ararat, abbandonando i viali di Yerevan alla lunga notte d'autunno. Il centro storico della capitale armena è il teatro in cui si assiste a uno spettacolo desolante che va in scena dagli anni novanta: la diaspora d'oltreoceano, forte del suo potere economico e ansiosa di marcare il territorio, invade col cemento armato ogni metro disponibile. Schiere di appartamenti disabitati, vetrine deserte, residenze d'estate, solitari agenti di polizia privata negli angoli della notte sono il lascito della politica del laissez faire che il governo armeno riserva alla sua diaspora. Nel tratto spietato del calcestruzzo si riconosce la stessa pena che la diaspora libanese infligge alla sua Beirut.
Stanco, mi rifugio nelle immagini raccolte nei territori in cui loro malgrado Armenia e Turchia si incontrano. La penna corre.
Dal mio diario
Il filo spinato spezza la continuità assoluta dell'altopiano. Una formica percorre un segmento di quella trama zincata, fin quando una raffica di vento la scaglia a terra. Oltre i reticolati, il Monte Ararat aggredisce l'orizzonte, vicino come sembrano solo le cose che non si possono toccare. Questo è il limes da cui turchi e armeni gridano da un secolo l'un l'altro: 'Hic sunt leones'. Queste sono le Colonne d'Ercole che reggono l'ultimo tratto ancora in piedi della Cortina di ferro. La formica, ignara, zigzaga a lungo tra i due paesi, prima di scomparire nella solitudine della prateria. E se invece di volare a Beirut tornassi indietro via terra?
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
Commenti
Log in or create a user account to comment.